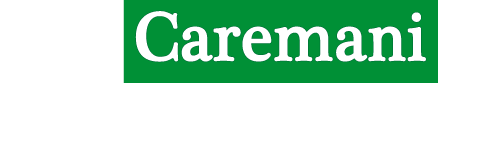Marca e il gol non gol dello sciopero
Alla fine Marca è andato in edicola, così come Expansion, entrambi con articoli non firmati dai giornalisti e notizie prese dalle agenzie. Dello stesso gruppo, invece, non è stato stampato El Mundo, anche se lo sciopero più incisivo è stato sicuramente quello di Radio Marca, l’emittente legata al quotidiano sportivo, che è rimasta in silenzio per un numero imprecisato di ore, proprio mentre a Monaco di Baviera l’Atletico Madrid conquistava la sua terza finale di Champions League e in attesa che questa sera riesca al Real. La manifestazione organizzata da giornalisti e dipendenti ha una portata storica, perché è la prima volta che accade al gruppo Unidad Editorial, controllato da Rcs, che attraverso questo aveva acquisito Recoletos, uno dei più importanti editori spagnoli, per 1,1 miliardi di euro; con gravi ripercussioni poi sulla casa madre italiana.
Lo sciopero di 24 ore è stato indetto contro l’azienda che ha programmato 224 licenziamenti, di questi 185 sono giornalisti, 33 di Marca e Radio Marca. I media spagnoli non ricevono finanziamenti pubblici e la situazione è drammatica. Dal 2008 al 2012 sono stati licenziati 4.868 giornalisti (Osservatorio Fape), mentre molti professionisti e redattori sono stati declassati al contratto base che non supera i 1.000 euro il mese. Già quattro anni fa il gruppo Unidad Editorial cercava un miliardo di euro per risanare i conti, dopo l’acquisizione del gruppo Recoletos, mentre ce ne volevano 5 al gruppo Prisa che tra gli altri edita El Pais, diretto concorrente di El Mundo.
Uno dei picchi più alti di vendite di Marca, il quotidiano sportivo più letto in Spagna, è stato raggiunto il giorno dopo la finale del 2014, quando il Real vinse 4-1 contro l’Atletico ai tempi supplementari. Uno dei motivi che hanno spinto l’azienda a farlo uscire nonostante lo sciopero, per evitare un’importante perdita economica. Episodio che ha fatto riflettere gli ambienti editoriali europei sul potere di ricatto che lo sport, il calcio in particolare, ha su vertenze così importanti. I giornalisti hanno presentato all’azienda un pacchetto di scioperi che oltre quello di ieri, 3 maggio, prevede altre 24 ore di fermo il 10, il 17 e poi ancora il 21 se non sarà raggiunto un accordo. Anche se pare che i negoziati inizieranno solamente il 27, cioè il giorno prima della finale di Champions League, considerando che entrambe le finali di coppa potrebbero essere totalmente spagnole.
Il 6 settembre 2011 ha chiuso per sempre Don Balon, storico settimanale spagnolo, confratello del Guerin Sportivo (oggi mensile e con 100 anni di storia alle spalle compiuti nel 2012). Nel frattempo France Football è diventato settimanale invece che uscire il martedì e il venerdì. In questi anni la Champions League ha spostato gli equilibri delle televisioni a pagamento, nel bene come nel male, in termini di abbonati e pubblicità. Il calcio, sopra ogni altro sport, ha ridisegnato i parametri del proprio storytelling con la precedenza a chi paga i diritti e le briciole agli altri, che al di là delle difficoltà oggettive non hanno saputo adeguarsi. In Spagna ci si chiede se il potere contrattuale dello sport sarà sufficiente a mantenere a galla i giornali specializzati.
Quello che sappiamo è che il calcio, considerando il caso specifico di Madrid, dove il futbol non è una passione ma una guerra di religione, tra chi crede nelle Merengues e chi nei Colchoneros, ha costretto a rivedere uno sciopero che altrimenti sarebbe andato in porto nella sua idea originaria: tra il timore di perdere il posto di lavoro da una parte e il timore di perdere lettori e introiti pubblicitari dall’altra. Nel mezzo ci sono i giornalisti e un lavoro che sta perdendo addetti quotidianamente (nel Regno Unito i comunicatori sono in numero pari ai giornalisti attivi). In questo caso ha vinto la Champions, ha vinto l’editore: anche se il giornale non è uscito con la quotidiana qualità. Una vittoria di Pirro, obbligata dalla grande offerta che oggi un tifoso può trovare, tra siti Internet e televisioni straniere. Ed è tutto questo insieme che riduce quasi a zero il potere contrattuale dei giornalisti, perché i media possono salvare il calcio, anzi lo hanno reso ultramiliardario (seppur con casi e paradigmi differenti da Paese a Paese) con i diritti televisivi, ma il calcio così come lo conosciamo e viene raccontato oggi non salverà più giornali e giornalisti.