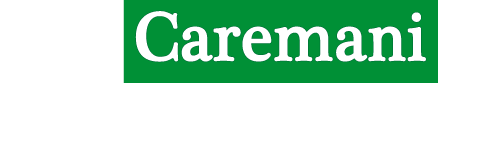Dream and Goal
Sogna e segna, segna e sogna. Un gioco di parole che Miriam Peruzzi, 33 anni, ha trasformato in realtà con la società di cui è presidente e direttore scouting, con due sedi: una in Gambia, l’altra in Benin. «Dream & Goal» attraverso la creazione di vere e proprie accademie cercherà di promuovere e sviluppare il calcio in West Africa, come dice Miriam, puntando sulla formazione dei giovani e su quella di staff tecnici africani: «Non si può raccontare l’amore che hanno per il football, lo si deve vivere».
Diplomata al liceo scientifico di Castiglion Fiorentino, nel suo sangue scorrono in misura uguale coraggio e senso per gli affari, gli statunitensi la definirebbero una entrepreneur o più correttamente businesswoman: «Avevo aperto degli store tecnologici a Empoli e Pontedera con il mio ex ragazzo. Ho lavorato in televisione, ho fatto la modella e poi ho capito che il lavoro in negozio non mi calzava, così ho deciso di lasciare tutto e partire per l’Africa, da sola». Andare cinquant’anni indietro per ritrovarsi cinquant’anni avanti, recuperando le radici più intime e profonde dell’essere umano: «Per avere un futuro migliore bisogna ripartire da se stessi, un passo indietro per farne due in avanti». Miriam ha vissuto un mese in Ghana, tra malaria e dissenteria ma con una determinazione non comune, cercando di conoscere e farsi conoscere.
Il terzo elemento presente nelle vene di questa ragazza toscana è proprio il calcio, grazie al padre: Giulio Peruzzi, ex calciatore e secondo di Paolo Indiani. Un amore intimo e profondo, come in ogni rapporto padre-figlia che si rispetti, che si è tradotto per quel lavoro e quell’impegno che lo portava in giro per gli stadi di mezza Italia: «Inizialmente, i miei genitori non l’hanno presa bene, poi però sono giovani e in casa siamo abituati a confrontarci. In quel mese ho capito che nonostante il gioco del pallone sia così importante per loro (africani, ndr), strutture e preparazione non sono minimamente all’altezza delle ambizioni. Ho iniziato a studiare, in questo sport non si deve mai smettere di farlo, e ho cominciato a preparare dei programmi insieme a mio padre, Paolo Indiani e l’ex del Torino Danilo Pileggi (che ha allenato il St. George in Etiopia vincendo il campionato, ndr)».
Occhi verdi ipnotici, severità svizzera e grande competenza il mix vincente che ha aperto le porte di ministeri e federazioni africani, il Benin nel dicembre del 2014 l’ha insignita del titolo di presidente onorario dei centri di formazione nazionali: «Ho trovato persone disposte ad ascoltarmi e capaci di darmi un’opportunità che io ho sfruttato, tessendo rapporti anche con importanti imprenditori locali, che in un futuro potrebbero investire nel calcio europeo, perché l’Africa è il continente di domani», sottolinea Miriam. Intransigente su regole e lavoro s’è trovata alla perfezione in una società di fatto matriarcale con i ragazzi che la seguono senza batter ciglio: «L’Africa non è quella che si vede in televisione o su Internet, è un’altra cosa, bellissima, complicata ma con risorse incredibili, economiche e umane».
La scelta è ricaduta su Gambia e Benin perché sono due Paesi stabili e relativamente tranquilli. Nelle accademie il personale sarà soprattutto italiano: «Oltre lo scouting organizziamo corsi per allenatori, fisioterapisti e tutto lo staff tecnico che oggi il calcio richiede. Ma non si tratta solo di questo, un calciatore deve avere anche una cultura, studiare la storia e la matematica, quindi ci stiamo attrezzando per offrire una formazione completa ai ragazzi africani. C’è poi l’aspetto dell’alimentazione, con una dieta bilanciata, perché non ci si può allenare senza mangiare. Le nostre accademie saranno organizzate come un collegio, ovviamente dando spazio ai migliori grazie a un sistema di borse di studio».
Non sono mancati momenti difficili e pericoli: «Ho dormito in baracche di fango e sterco, ho camminato scalza in mezzo all’immondizia, ho vissuto istanti in cui mi sono detta “ma chi te l’ha fatto fare”, ma alla fine eccomi qua. Paura? Mai, perché ho una grandissima fede in Dio, ognuno ha il suo percorso e quando lui vorrà io sono pronta. Una volta è venuta a trovarmi una mia amica e dopo due giorni voleva scappare». Tifosa della Roma, ammira Luciano Spalletti e anche Francesco Totti, professionista e bravissimo allenatore il primo, carisma e personalità il secondo. Non guarda la televisione, ma legge molto: «Gli scrittori inglesi dell’Ottocento, in particolare Emily Brontë: aiuta a staccare, a liberare la testa quando hai tanti pensieri». L’Italia, la casa a Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo, è diventata il suo buen retiro: «Tutto quello che ho fatto lo devo alla mia famiglia, alla serenità che mi hanno infuso e il babbo è l’uomo più felice del mondo, orgoglioso di una figlia che si batte per quello che ama… chi l’avrebbe mai detto cinque anni fa».
Nel frattempo sta aiutando Gloria, figlia del console italiano in Benin, a promuovere nuovi talenti musicali africani: «Davido è nigeriano ed è bravissimo». Dall’anno scorso, invece, setaccia i centri d’accoglienza italiani per dare una chance attraverso il calcio: «Chi è in regola con il permesso di soggiorno può avere un’opportunità, come Moussa Balla Sowe che ha giocato nel Parma», in patria militava nell’FC Banjul United. Critica nei confronti dei limiti degli extracomunitari è convinta che gli italiani siano i più bravi a insegnare football: «Non esiste scuola migliore. Il problema è che qui (in Italia, ndr) vai avanti solo se sei stato un calciatore professionista, basta vedere quanta fatica ha fatto Sarri per emergere. Qualcuno poi dovrebbe chiedersi come mai i nostri vivai non producono più certi giocatori, la Nazionale di oggi, nomi alla mano, non mi pare uguale a quella di dieci anni fa». «Come mi vedo tra due lustri? Presidente della Fifa», segna e sogna, sogna e segna Miriam.